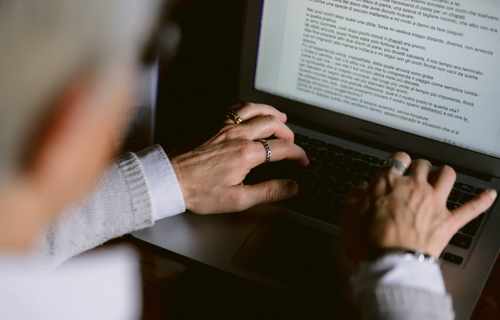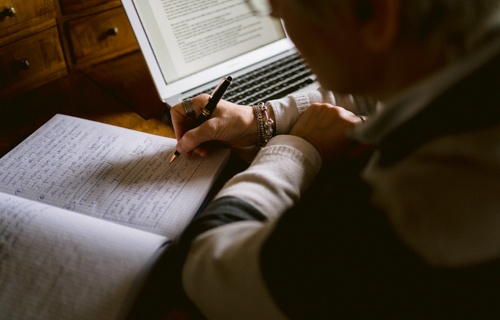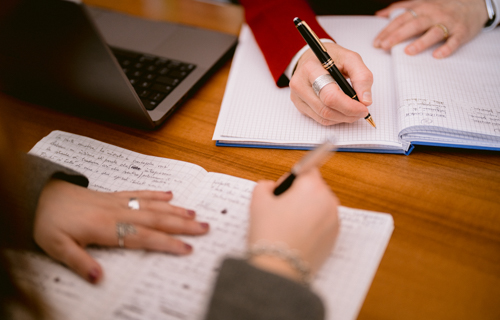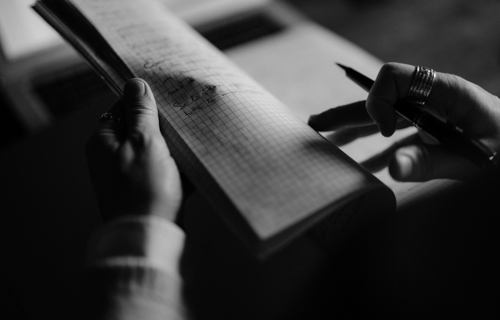Mi è capitato di leggere più di un libro nel quale l’autore aveva scelto di abolire tutti, o quasi, i dialoghi, almeno nella forma che siamo abituati ad incontrare in un testo.
Ossia: trattino, aperte virgolette – oppure caporali -, frase, chiuse virgolette, trattino, disse…
La lettura si era rivelata comunque piacevole e comprensibile, senza difficoltà nel distinguere i personaggi che di volta in volta si avvicendavano nel racconto.
La domanda quindi è: sono proprio necessari i dialoghi?
E poi: a che cosa servono i dialoghi? Perché ci piacciono?
Diamo uno sguardo alla storia e facciamo qualche considerazione.
Partiamo dalle origini
La parola dialogo deriva dal latino dialŏgus, conversare, discorrere, ed è composta da dià, attraverso, e logos, discorso.
Questo indica il flusso del pensiero, che, da una prima persona che lo esprime, ha come intento quello di raggiungere uno o più interlocutori, con lo scopo di mettere a confronto le idee.
Si è soliti attribuire la paternità del dialogo a Socrate, che attraverso l’arte della maieutica, segnò il punto di svolta da una cultura di tipo orale – nella quale l’autore decideva se impersonare la voce narrante oppure parlare attraversi i propri personaggi-, ad una nuova mentalità che vedeva nella dialettica il mezzo per esprimere e confrontare concetti di diverse origini.
Prima di Socrate, la forma orale più diffusa era il monologo: una persona colta parlava davanti ad una platea che però poteva solo ascoltare.
Il dialogo quindi introduce un concetto importante, che prende vita attraverso l’ascolto, il confronto delle idee, l’interesse verso un possibile pensiero diverso.
Queste considerazioni trovano concretezza nei libri che leggiamo, dove incontriamo personaggi che:
- parlano e qualcuno li ascolta;
- rispondono o formulano nuove domande;
- esprimono un’idea o un sentire nuovo.
Ognuno di loro, attraverso l’autore, racconta una storia, in forma aderente alla realtà o in completa fantasia: uno spaccato di vita, un sogno irreale o un futuro imprecisato.
A cosa serve il dialogo?
Il dialogo rappresenta lo strumento per eccellenza per condividere pensieri, sapere, emozioni: la sua funzione principale è quella di trasferire un costrutto sintattico da chi parla a chi ascolta.
Nel caso di un libro, dall’autore – attraverso i personaggi – al lettore.
Per riuscire in questo intento, lo scrittore dovrà delineare i particolari che identificano ogni personaggio, cesellarne il carattere e definire il registro espressivo di ognuno.
Insomma, si tratta di dar vita a soggetti diversi che popoleranno le pagine, animeranno le vicende e, proprio come in un film, creeranno quel susseguirsi di azioni in grado di suscitare l’interesse del lettore.
Il dialogo diventa quindi parte essenziale nella narrazione: dovrà essere congruo e funzionale all’intreccio del racconto, rispecchiare la personalità, la cultura ed il contesto sociale nel quale si trovano immersi i personaggi ai quali è riferito.
Con queste premesse, quali sono le funzioni principali del dialogo?
- Far progredire l’azione: rompere il ritmo della voce narrante facendo parlare i personaggi, consegnando al lettore informazioni nuove su quanto si sta raccontando.
- Caratterizzare ogni personaggio attribuendogli una voce ben definita, che evidenzi il carattere e lo stato d’animo rendendolo unico e distinguibile nel testo.
- Contestualizzare il tempo ed il luogo in cui si volge l’azione.
- Far emergere l’elemento essenziale che non deve mai mancare: la contrapposizione che prenderà vita fra i personaggi, oppure il conflitto interiore che caratterizza, in genere, il protagonista.
Tutto questo permetterà al lettore di immedesimarsi nella storia e muoversi, con la mente e le emozioni, attraverso il ritmo delle vicende narrate.
Perché ci piacciono i dialoghi?
Abbiamo capito l’importanza di un dialogo e intravisto le linee guida.
Ma il vero motivo per cui tutti amiamo i dialoghi è che ci riportano al parlato o, più propriamente, al racconto che ascoltavamo, quello che fin da piccoli abbiamo sentito leggere per noi, e poi ritrovato nei primi libri di favole.

Tutto questo – parte della nostra storia – abbraccia un concetto molto più ampio che riguarda lo sviluppo dell’essere umano e le sue competenze cognitive.
La capacità espressiva ed il passaggio dalle parole isolate alla formulazione delle prime domande segnano una tappa fondamentale nello sviluppo del bambino: siamo difronte ad un primo dibattito con un altro essere umano.
Da un punto di vista antropologico le domande, e quindi il dialogo che ne deriva, sfruttando una predisposizione biologica naturale, rappresentano la fonte primaria di conoscenza per un bambino1.
Uno studio condotto dall’Università di Bath (UK) nel dicembre 2020, ha dimostrato come i bambini apprendano più rapidamente attraverso il racconto di storie piuttosto che da attività di gioco o didattiche2.
Trasferendo questi concetti nella narrativa, domande e risposte altro non sono se non ciò che raccontano due personaggi attraverso la forma del dialogo.
Arriviamo quindi al concetto che, per scrivere dialoghi efficaci, sarà importante ritornare al parlato, al linguaggio del tempo in cui si svolge l’azione, al carattere dei personaggi e soprattutto alla storia che si vuole narrare.
Cosa succede nel cinema
Diamo uno sguardo al mondo cinematografico, che spesso trae origine proprio dai romanzi, suggellando quel rapporto che esiste fra letteratura e cinema.

È dai film che possiamo prendere spunti per approfondire bene il concetto di dialogo efficace.
Quando guardiamo un film spesso sottolineiamo l’importanza di un dialogo affermando che non si deve perdere nessuna parola, tanto sono importanti e determinanti al fine della comprensione di quel particolare passaggio.
Fra i dialoghi più famosi nella storia del cinema, che di sicuro rimarranno tali ancora per molti anni, meritano di essere ricordati quelli fra Hannibal Lecter – Anthony Hopkins -, serial killer rinchiuso in un carcere di massima sicurezza, e Clarice Starling – Jodie Foster -, recluta dell’FBI – Sezione comportamentale, protagonisti de “Il silenzio degli innocenti”, film del 1991, vincitore di 5 premi Oscar, tratto da un romanzo di Thomas Harris.
Ancora oggi è considerato un classico della filmografia mondiale nonché uno dei migliori thriller che il cinema ricordi.
Negli incontri fra il killer-Hannibal e l’agente-Clarice i dialoghi assumono la valenza di vere e proprie sedute di psicanalisi.
Per questo motivo, ad ogni successiva visione, si coglie un aspetto nuovo, magari sfuggito nella precedente, e, nonostante le scene di dialogo fra i due protagonisti non superino i 15 minuti, rappresentano l’aspetto più importante e di maggior impatto emotivo, a conferma sì della bravura degli attori che li hanno caratterizzati, ma anche, prima di tutto, di chi ha scritto quelle sequenze.
Leggere dialoghi in un libro, come è noto, richiede presenza e complicità del lettore che, attraverso la propria immaginazione, riuscirà a calarsi nella scena descritta, immedesimarsi nei personaggi – o in uno di essi – e passare il tutto al vaglio della propria intelligenza e sensibilità.
La lettura ci fornisce quindi la chiave per vivere l’azione assieme ai personaggi.
Nella finzione cinematografica, invece, avviene qualcosa di differente: nonostante la bravura degli attori, della scenografia in grado di trasportarci dentro le immagini, nonché del ruolo fondamentale della musica che accompagna certe scene, siamo spettatori di qualcosa che accade davanti ai nostri occhi, rimanendo solo osservatori esterni.
Un altro esempio di dialoghi, calato nel mondo dei più piccoli, sono quelli che animano il film “Marry Poppins”, di Robert Stevenson, con protagonista Julie Andrews, uscito nel 1964, e vincitore di 5 premi Oscar.
In questo film si possono ritrovare le semplici domande, frutto di curiosità, che i due bambini, Michael e Jane Banks, rivolgono alla loro tata, Mary Poppins, la quale, utilizzando una forma di dialogo semplice ed immediato, trasformerà quei momenti in importanti lezioni di vita.
E se facessimo a meno dei dialoghi?
Torniamo ora al tema principale: la scelta di alcuni autori di portare avanti la narrazione senza dialoghi.
Attenzione però, senza dialoghi nella forma che siamo abituati a leggere, non senza confronto verbale fra i personaggi di un libro.
Non dobbiamo confondere la mancanza di dialoghi con un monologo o con la scrittura nel flusso di coscienza.
Quando parliamo di monologo – parola che deriva dal greco monológos, composta da mónos, solo, unico, e lógos, discorso – ci riferiamo ad un pensiero o una riflessione, in forma orale o scritta, che una persona rivolge a sé stessa o ad altri, senza che sia previsto alcun rapporto di reciprocità, scambio di opinioni o critiche.
Esempi di testi con monologhi famosi sono facilmente riscontrabili nella letteratura teatrale o cinematografica.
Il flusso di coscienza invece, riguarda una tecnica narrativa che prevede di scrivere i pensieri così come affiorano nella mente dello scrittore, in maniera ininterrotta, senza porsi il problema di seguire regole di sintassi o legami logici: seguire ciò che si pensa e fermarlo in un testo.
Questo tipo di scrittura riguarda ciò che viene definito monologo interiore, dove l’individuo diventa protagonista manifestando i propri intimi dissidi, le emozioni, le paure, delineando così le sembianze del suo inconscio.
Il più famoso esempio di scrittura nel flusso di coscienza riguarda il monologo di Molly Bloom, la moglie del protagonista dell’Ulisse, un romanzo sconfinato, composto da più di mille pagine, dello scrittore, poeta e drammaturgo irlandese James Joice (Dublino, 1882 – Zurigo, 1941); la prima edizione originale risale al 1922, in Italia al 1960.
A questo punto non mi resta che suscitare la vostra curiosità riguardo la scrittura senza dialoghi proponendovi, per esempio, questi due testi che ho letto e che, per motivi diversi, mi hanno colpito.
Il primo è di uno scrittore islandese.
La sua scrittura può risultare in alcuni passaggi scarna e graffiante, e, come risultano le persone poco empatiche, forse un po’ distaccate: rudi a tratti, come il territorio nel quale è ambientata la vicenda, che lascia poco spazio alla fantasia, con forti richiami alle difficoltà della vita.
Il secondo libro è caratterizzato da una scrittura molto scorrevole, immediata, seppur dura, a volte, per la realtà nella quale si muovono i personaggi, che in alcuni momenti assumono le sembianze di figure incredibili da incontrare, immerse in vicende dai risvolti impensabili.
Il testo si è posizionato al quarto posto del Premio Strega 2021.
Di seguito un breve estratto di entrambi.

1 – da “CREPITIO DI STELLE”
di Jón Kalman Stefánsson- Ed. Iperborea S.r.l. Milano – 2020
… Frikki è stato cosi gentile e dispiaciuto, la bocca talmente piena di parole pettinate che ero quasi sul punto di dirgli: buon per te, senti, piantala con questa storia e picchiami, perché non so che cosa sia peggio, il Frikki di oggi o quello della settimana scorsa.
…Frikki si ferma tra le piante, si piega sulle ginocchia, fruga distrattamente nella terra, dice che da tanto tempo ha la sensazione che io sia l’unico che lo può capire. L’unico disposto a perdonarlo. lo sarei così insomma, poi si mette a parlare della mia mamma. Io sussulto come dopo un colpo di pistola, perché chi viene colpito da un proiettile ha un sussulto.
lo avrei pianto tantissimo se fosse morta lamia mamma, mi dice Frikki a voce bassa, eppure ti ho torturato e picchiato tutte quelle volte, che cazzo di stronzo che sono stato. lo borbotto qualcosa che potrebbe essere pressappoco: su, dai, non importa, ma lui scuote la testa e dice no, no, eccome se importa! Insomma, credi di potermi perdonare anche se non me lo merito, eh? Possiamo essere amici? Cioè, la penserai di continuo, no? E devi anche sognartela spesso, è vero? Frikki ha smesso di rovistare per terra, mi guarda dritto in faccia, tenero come Gesù con quei suoi occhi celesti. Frikki scuote la testa molto lentamente, avere una mamma morta, dice a Voce bassa, è terribile!
2 – da “L’ACQUA DEL LAGO NON È mai DOLCE”
di Giulia Caminito – Giunti Editore S.p.A./Bompiani – 2021
Allora mia madre la aspetta, porta giù i gemelli e me e Mariano e ci ordina di andare contro il muro, levarci le magliette e se la leva anche lei, si mette in reggiseno appoggiata al muro come una condannata alla fucilazione e quando la tedesca col marito arrivano, lei gli dice: Se non fate scendere la ragazza in giardino noi restiamo qui, tutti i giorni, io e i miei figli, senza vestiti, a protestare.
Lo urla e la gente si affaccia alle finestre che danno sull’interno e la tedesca rimane immobile, stoccafisso, attaccapanni poi dice: Chiamo i carabinieri.
Li chiami, noi non ci muoviamo. Come si fa a negare a una bambina di stare al sole? Una bambina che non può camminare.
Dirò questo ai carabinieri e se ci cacceranno torneremo, lei non sa quanto posso essere cocciuta se voglio, proprio non lo sa.
Interviene il marito della tedesca mentre loro strillano e noi ce ne stiamo mezzi nudi incollati alla parete, Mariano s’è messo in mutande, io ho la gonna alzata.
Siamo pronti per la rivoluzione.
Li vede questi cancelli? domanda il marito della tedesca, che è di sicuro più vecchio di lei di una decina di anni. Li abbiamo rimessi noi dopo la guerra, perché i fascisti li avevano rubati, questo palazzo ha una storia, lo fa notare con pacatezza e maggiore stizza e forse quella sua calma velenosa fa adirare mia madre ancora di più.
E chi sono i fascisti adesso, eh? A voi importa dei cancelli e non dei bambini, non li fate giocare, né un saluto né una carezza, non li fate neanche stare seduti in un angolo, che gente siete? lo mi sono quasi presa l’AIDS per far giocare i miei figli.
La donna dai capelli rossi si batte una mano sul petto e sul braccio fa il gesto di una siringa.
Loro non sanno cosa rispondere, stanno zitti.
Noi, al segnale convenuto, ci rivestiamo e seguiamo Antonia a casa in fila indiana, lei dichiara che torneremo.
Alcune considerazioni personali
Senza dialoghi, delimitati in schemi come quello descritto all’inizio, la scrittura risulta più aderente al flusso del parlato.
È un po’ come se guardassimo un film e provassimo a chiudere gli occhi.
Il senso del dialogo, le pause, il cambio di personaggio, arriverebbero ascoltando le diverse voci, il tono, il modo di parlare, se lento o veloce, concitato o calmo.
Prestando più attenzione a queste caratteristiche, anche nello scritto riusciremo a seguire il senso del discorso o del racconto, a patto però che lo scrittore abbia delineato bene i personaggi, in modo da rendere possibile capire chi parla solo leggendo il susseguirsi delle parole.
In questo modo non sentiremo il bisogno di vedere trattini, virgole, punti esclamativi o caporali, che separano gli interventi dei personaggi coinvolti nel dialogo.
Se vorremo scrivere, o affidare un nostro manoscritto ad un Editor, ricordiamo di controllare e attribuire la giusta importanza anche ai dialoghi e, soprattutto, non dare mai per scontato che tanto quelli vanno bene: spesso rappresentano una delle parti più difficili da scrivere.
Teniamo ben presente anche questi dettagli, oltre a quelli incontrati in precedenza, quando scriveremo dei dialoghi:
- non dovranno essere vuoti, come a volte succede nel parlato, perché
- potrebbero rallentare il ritmo narrativo del testo
- il lettore potrebbe perdere interesse o addirittura annoiarsi;
- sarà importante delineare molto bene il carattere dei personaggi attraverso il registro linguistico, per far si che possano essere riconosciuti;
- dovremo creare un’atmosfera adeguata alla scena raccontata affinché il lettore posa immedesimarsi nel testo.
Provare a scrivere, anche solo per noi, rappresenta sempre un passo importante e utile.
Potremo decidere in seguito cosa fare del nostro testo: se tenerlo per noi, o pensare di affidarlo alla stampa.
Ma di questo ci si può occupare in un secondo momento.
Qualunque sia la tua decisione,
parlarne con un Editor o un Writer Coach può fare la differenza.
Se vorrai, sarò felice di seguirti, qualunque sia il percorso che sceglierai.
1 Approfondimenti: https://www.nostrofiglio.it/bambino/psicologia/apprendimento-nei-bambini
2 Approfondimenti: https://www.bath.ac.uk/announcements/pupils-can-learn-more-effectively-through-stories-than-activities/