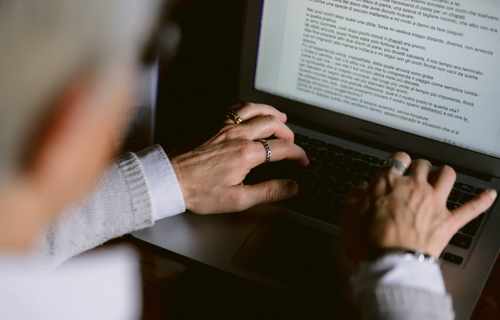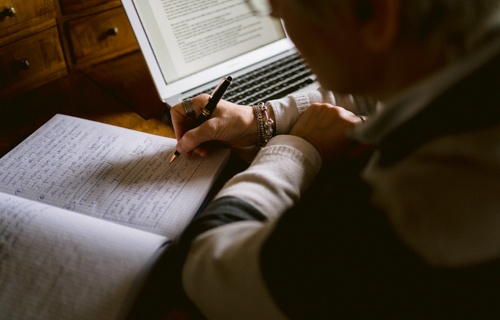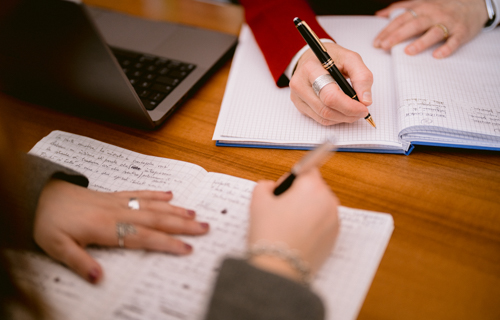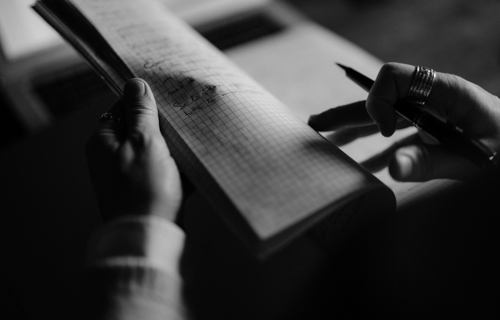La nostra personalità è un insieme poliedrico di aspetti preziosi e complessi al tempo stesso. Comprende gli interessi, l’attività, le passioni che coltiviamo e, non per ultimo, il tipo di rapporto che siamo in grado di instaurare con le persone accanto a noi.
Potremmo dare un’interpretazione e sviluppare quest’ultimo punto considerando anche come manifestiamo, o siamo in grado di esercitare, la nostra leadership.
Ho avuto modo di confrontarmi con questo concetto seguendo due corsi che prevedevano di interagire con i cavalli.
L’importanza e la profondità di quell’esperienza furono subito evidenti già alla fine del primo corso.
Da considerare per entrare nel mondo del cavallo
Come ogni erbivoro, quando vive allo stato brado, il cavallo rappresenta una preda per i cosiddetti “consumatori terziari” della catena alimentare: per questo motivo l’istinto suggerisce all’animale il bisogno di un capo.
Una volta stabilito chi occuperà questa posizione, ogni cavallo all’interno del branco riconoscerà in lui una guida in grado di proteggerlo, avvertirlo in caso di pericolo e condurlo dove poter pascolare in tranquillità.
Questo atteggiamento, che può sembrare di sottomissione, non offuscherà mai il bisogno istintivo dell’animale di mantenere uno spazio proprio da difendere.
Per noi umani, entrare in “questa zona di fiducia” implica regole precise e severe, da imparare e seguire senza mai metterle da una parte.
Riusciremo a fare amicizia col cavallo, godremo della sua fiducia,
ma se abbasseremo la guardia, non tarderà a voler imporsi su di noi.
Se dovesse succedere, però, dovremo riconoscere che saremo stati noi a permetterlo.
Il cavallo avrà colto un momento di distrazione interpretandolo come un calo della nostra leadership e ne avrà subito approfittato.
Fu proprio grazie a un episodio di questo genere che mi resi conto dell’importanza di proteggere il proprio spazio e del concetto di leadership.

Il cavallo che mi fu assegnato si chiamava Gitano: seppi alla fine che era il capo branco.
Era un esemplare maestoso, bianco con piccole macchie nere, dal carattere docile da non confondere però con debole. Anzi.
I primi due giorni furono molto pesanti, ricchi di insegnamenti tecnici: imparammo ad utilizzare la capezza annodata – soprattutto come fissarla al muso del cavallo -, e il frustino con corda lunga da allenamento con il quale iniziammo a prendere confidenza, soprattutto come strumento dedicato all’addestramento.
Nonostante gli sforzi e la mia buona volontà, però, Gitano non mi ascoltava.
Alla fine della seconda giornata uno degli esercizi prevedeva di impartire un particolare ordine, voltare le spalle all’animale ed allontanarsi di qualche passo.
Come risultato il cavallo avrebbe dovuto rimane fermo fintanto che il suo riferimento umano non lo avesse chiamato.
Il mio errore fu evidente perché, dopo un po’, Gitano, senza che me ne accorgessi, si avvicinò a me per mordicchiarmi su un fianco.
Ed ero stata io a permetterlo.
Dovevo analizzare me stessa: era importante capire dove avevo sbagliato.
Il mio cavallo si era accorto di un calo di attenzione, lo aveva interpretato come un varco nella mia leadership e la sua reazione non si era fatta attendere.
Per qualche motivo lo avevo deluso, non ero più una guida per lui, e, a modo suo, me lo aveva fatto capire.
Vivere questo tipo di esperienza – e soprattutto rendersi conto che è un cavallo a farti notare una tua mancanza – ti fa comprendere che esiste solo un modo per trasmettere un ordine.
Non significa usare forza o prepotenza, ma deve essere quello corretto, altrimenti l’animale non ti seguirà.
Le parole della mia istruttrice furono
“Con il cavallo, metti i confini: capirà chi è il leader e si rilasserà.”
Non ho più dimenticato l’importante lezione appresa da Gitano.

Questo meccanismo funziona tra essere umano e cavallo, ma come si traduce all’interno di un contesto sociale?
Quale insegnamento si deve cogliere da questa esperienza?
In ogni ambito della nostra vita dovremmo imparare a trovare la condizione migliore per poter esercitare, in modo sereno e mai arrogante, fermezza e coerenza, al fine di dare il meglio di noi, consapevoli di ciò che riceveremo, o potremmo ricevere, in cambio.
Il cavallo si affida all’istinto, spinta naturale verso un comportamento affinato in migliaia di anni di evoluzione, e indica all’animale il comportamento più adeguato in relazione alla situazione.
Lo avverte quando rimanere vigile nei confronti di possibili predatori, lo guida nelle azioni necessarie a soddisfare i bisogni primari, gli suggerisce come allevare la prole e trasmettere, attraverso l’imprinting, gli insegnamenti più importanti riguardo la conservazione della specie.
Noi esseri umani, disponiamo di facoltà come ragione, emozioni, sentimenti.
Grazie alla cultura ed alla sensibilità personale siamo in grado di instaurare relazioni più complesse e funzionali al contesto in cui viviamo, stabilire contatti con le persone, fondati su amicizia, comprensione, collaborazione: tutto ciò che rende speciale e unica la relazione con gli altri esseri umani.
Prima di tutto però c’è la persona, la sua personalità e individualità, che si esprime in base alle qualità che la definiscono come singolo individuo.
Possiamo riassumere quindi affermando che ogni essere umano è dotato di un insieme di elementi caratterizzanti, che lo rendono idoneo ad entrare in relazione con la realtà circostante.
La modalità che sceglieremo per esprimere la nostra individualità dipenderà da noi.
Se all’inizio non riusciremo a ottenere i risultati sperati, non servirà cedere a quella vocina – che non tarderà ad arrivare – nella nostra mente che ci suggerirà
“tanto non ce la puoi fare”.
Avremo solo fatto il gioco di chi avremo difronte: che sia un cavallo, un collega o un’altra figura che in quel momento si porrà in contrapposizione con noi.
Rimanere decisi e risoluti non significa essere prepotenti e aggressivi: significa aver chiaro il proprio proposito, conoscere i passi da intraprendere per raggiungere l’obiettivo, e soprattutto le modalità da adottare in funzione dell’ambiente nel quale operiamo.
Alcune persone ritengono che la leadership corra parallela al concetto di comando, ma, se così fosse, sarebbe un grave errore da parte di chi si appresta ad esercitarla.
Leader è colui che, all’interno di un gruppo, è in grado di coordinare i colleghi, ascoltandoli in maniera attiva ed accompagnandoli, al tempo stesso, ad acquisire autorevolezza all’interno del team.
Pensiamo ad alcuni ambiti nei quali è necessario un leader.
Nel lavoro dovrebbe essere la figura in grado di coordinare un gruppo di persone, considerare ogni loro contributo, e motivarle nell’attività all’interno del team.
In un’orchestra il leader è rappresentato dal primo violino: trasmette gli orientamenti interpretativi, definiti dal direttore d’orchestra, ai vari maestri dell’organico.
In politica è la persona posta a capo di un partito: a lui spetta il compito di definire la linea di pensiero del proprio gruppo e trasmetterla all’elettorato.
Il concetto di leadership rappresenta quindi il fulcro di un comportamento basato sul reciproco ascolto e sul rispetto delle persone alle quali è rivolto.

Un leader deve aver chiaro l’obiettivo da raggiungere – anche se consapevole delle difficoltà che potrebbe incontrare – con la necessaria determinazione per trasformare ogni ostacolo in motivo di apprendimento e crescita personale.
Come? Prima di tutto mostrando coerenza nelle azioni.
Quel comportamento definito dal motto, ormai entrato nell’uso comune, “walk the talk”.
La cosa più importante sarà quindi l’esempio che potrà
offrire mettendo in pratica ciò in cui crede.
Dovrà inoltre essere in grado di fornire sempre nuovi stimoli ai propri collaboratori, riconoscerne i successi, permettendo loro di crescere e lasciare spazio al consolidamento di ogni singola figura.
Potremmo avere ancora qualche dubbio, non sentirci a nostro agio parlando di leadership: forse pensiamo di non possedere questa attitudine, oppure non riteniamo che il problema ci riguardi, o semplicemente non sappiamo come sfruttare al meglio questa qualità.
La scrittura potrebbe rappresentare uno strumento in grado di aiutarci.
Come?
Proviamo a prendere nota di ogni accadimento durante la nostra giornata, con un occhio rivolto a come interagiamo con le persone che incontriamo per lavoro o altro.
Osserviamo, e scriviamo, chi sono gli attori, com’è il loro modo di entrare in scena e soprattutto le reazioni: come saranno le nostre e quelle che riceveremo in risposta.
Soffermiamoci soprattutto – ma non soltanto – quando non coincideranno con le nostre aspettative, oppure se, per qualche motivo, ci sembreranno inadeguate.
Alla fine rileggiamo il nostro scritto:
– controlliamo le caratteristiche del nostro approccio iniziale all’interno di quella relazione;
– verifichiamo le risposte comportamentali che ne sono conseguite;
– analizziamo gli atteggiamenti – nostri e di chi si contrapponeva a noi – alla ricerca di possibili errori o espressioni, verbali e non, che potevano essere evitate.
Prendiamo nota anche degli aspetti positivi che abbiamo osservato: applicare la stessa analisi descritta in precedenza ci condurrà a comprendere l’approccio migliore, quello che potrebbe restituirci un feedback positivo nelle relazioni con gli altri.
Forse non sarà sempre così, ma spesso usciremo sorpresi da ciò che emergerà.
E saremo stati noi a trovare la risposta.
Si, è vero. Servirà un po’ di allenamento a questa pratica.
Saranno necessarie le domande giuste,
quelle che non dovremo aver paura di porci.
Se ti piace l’idea, possiamo farlo assieme.